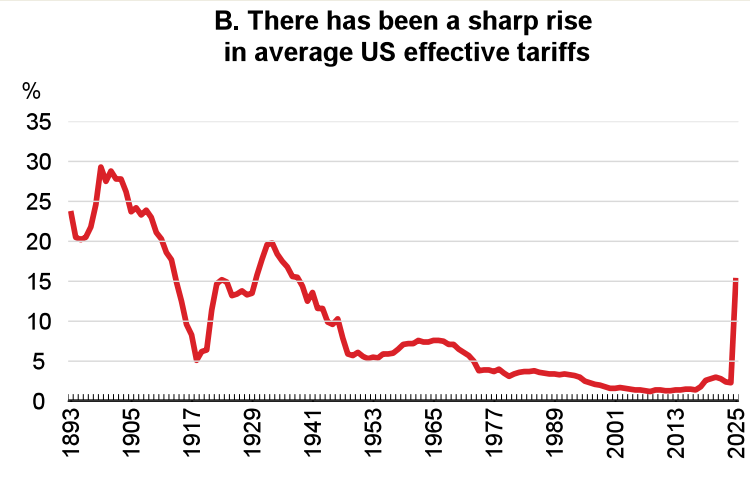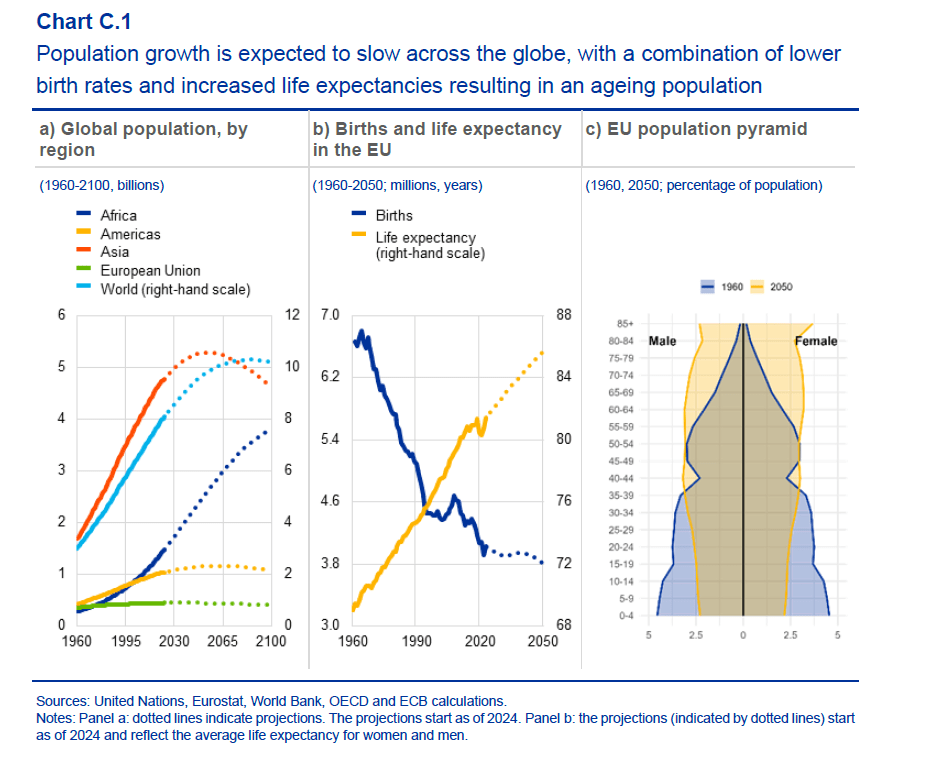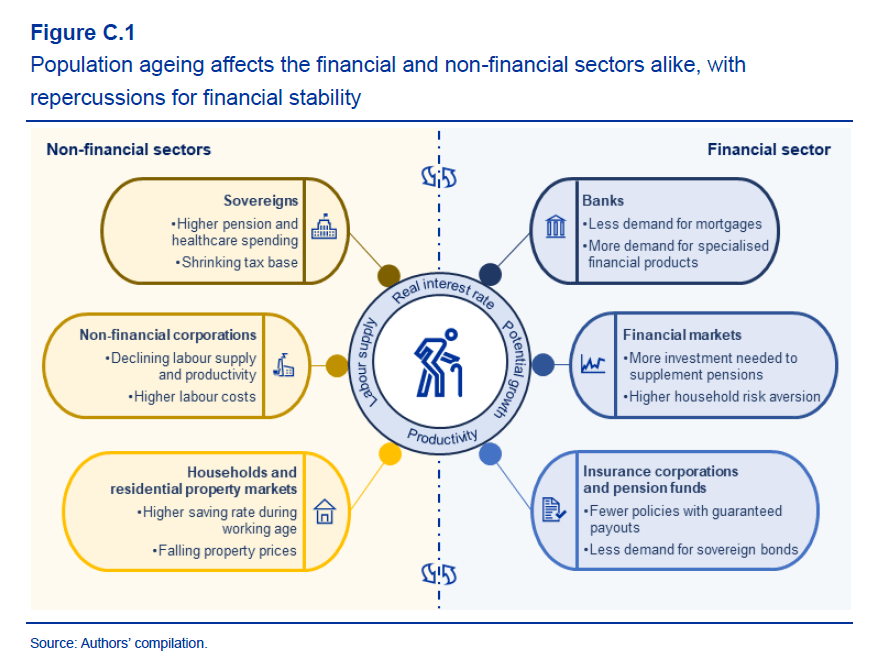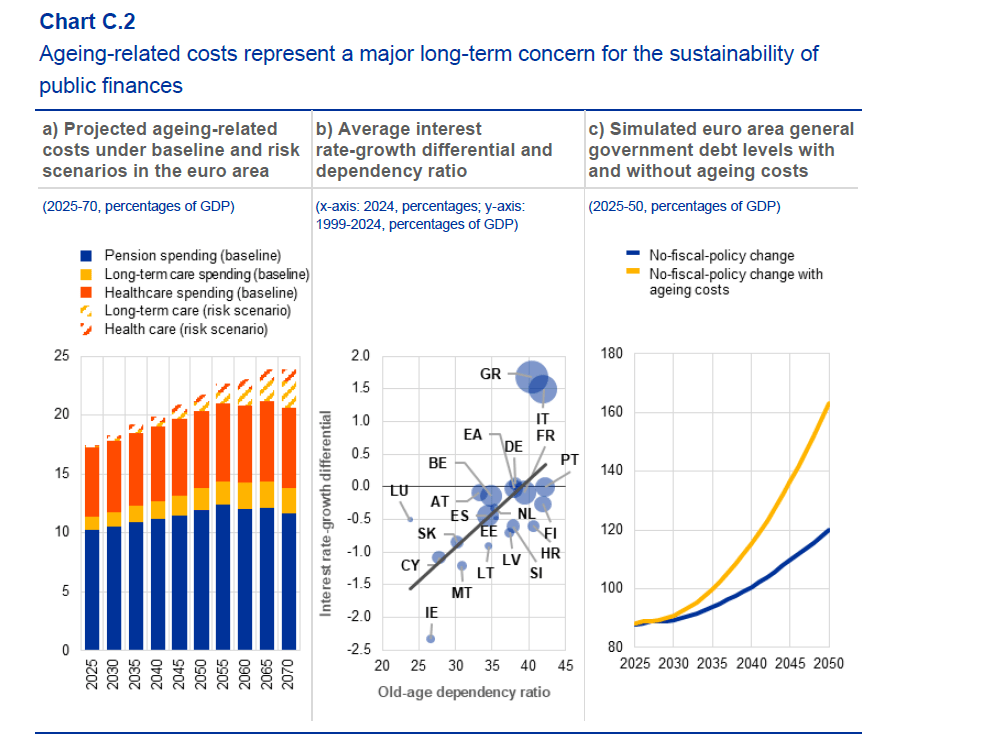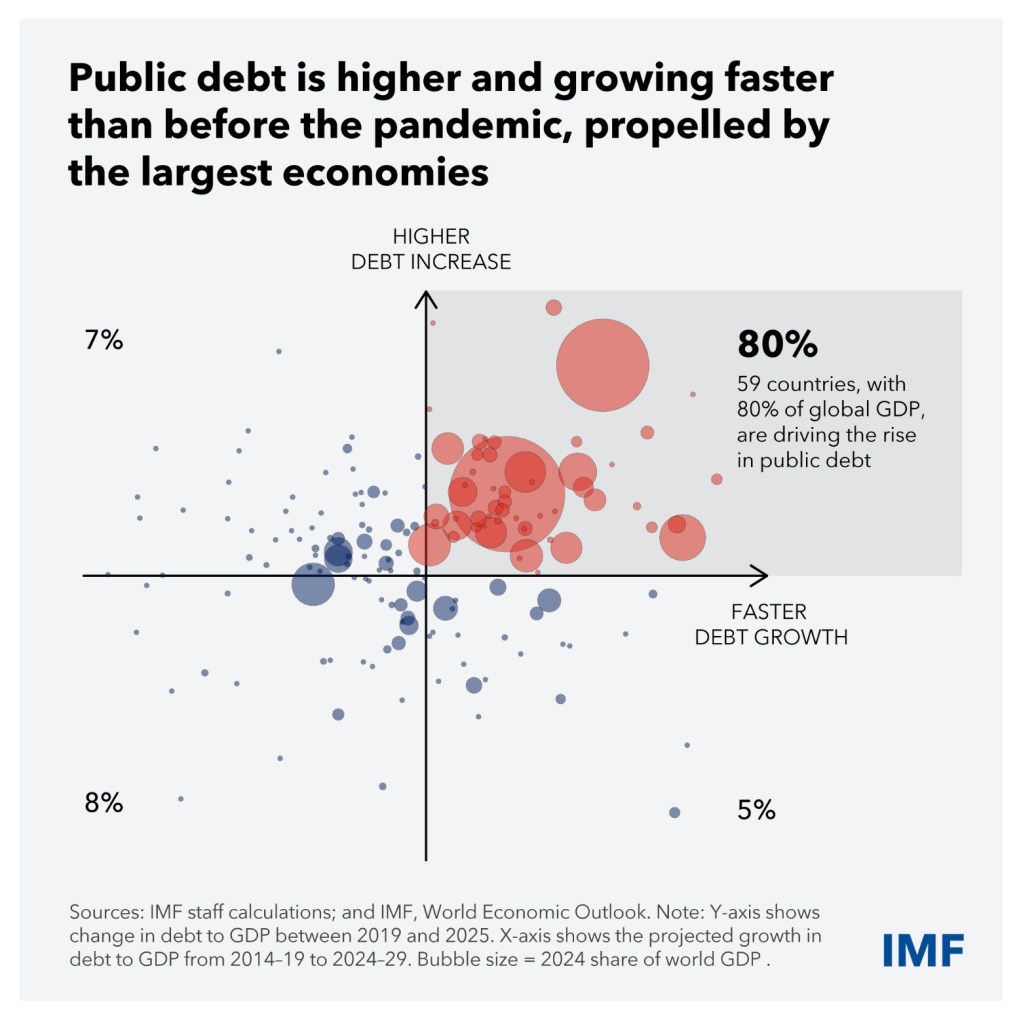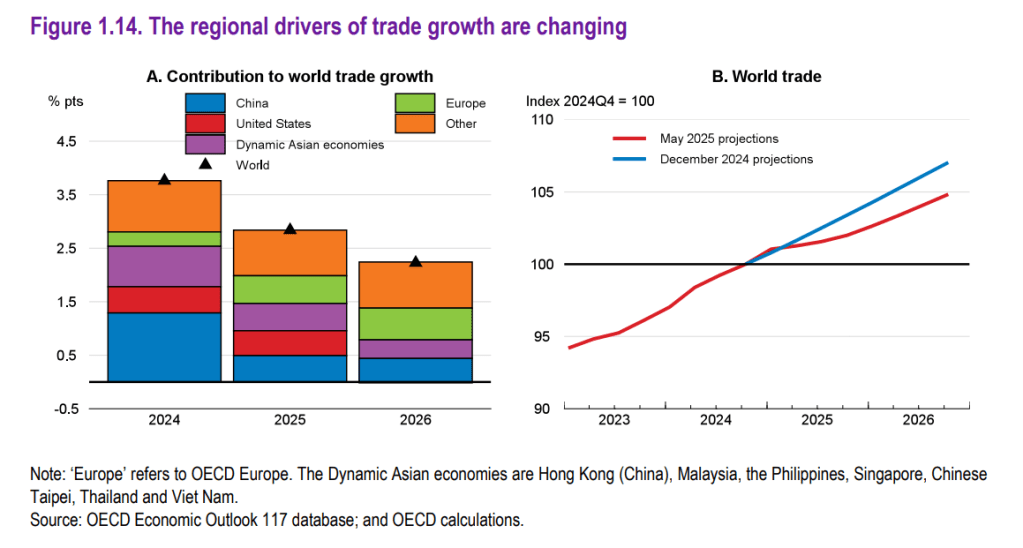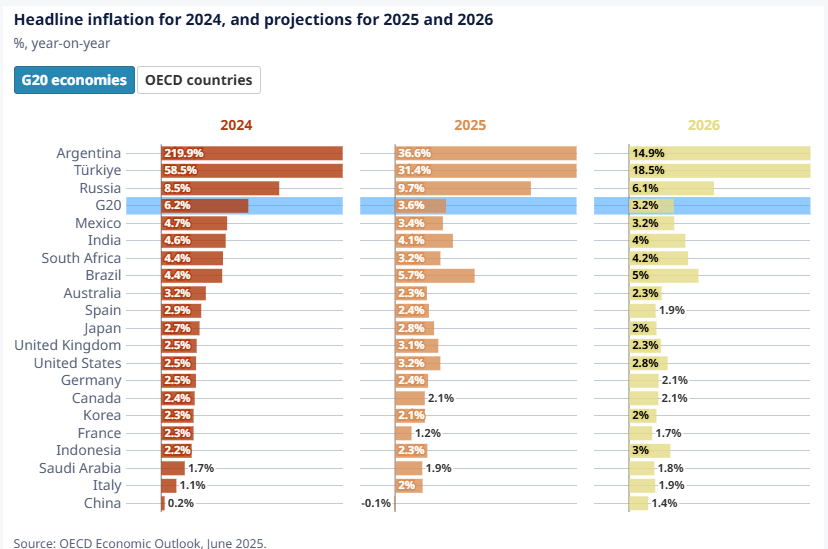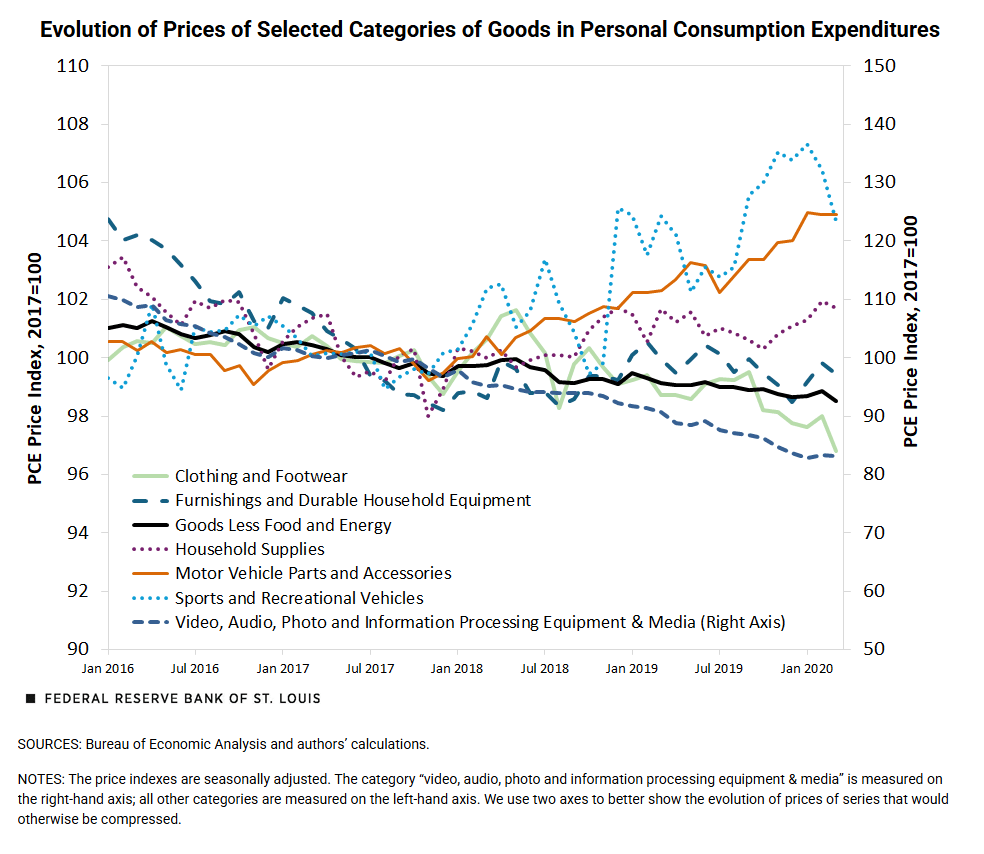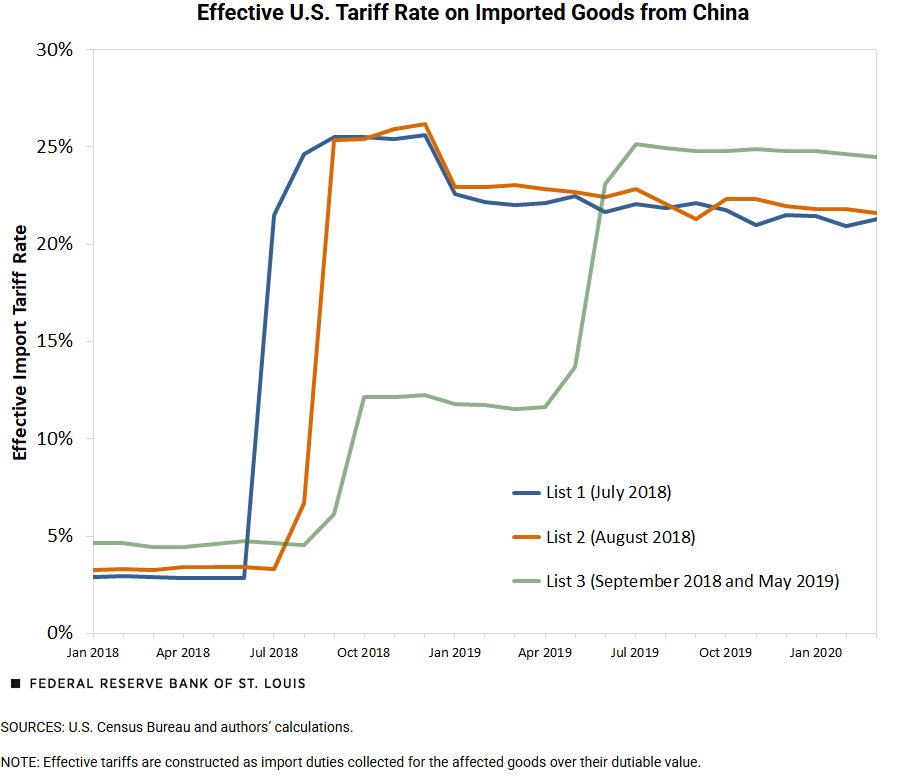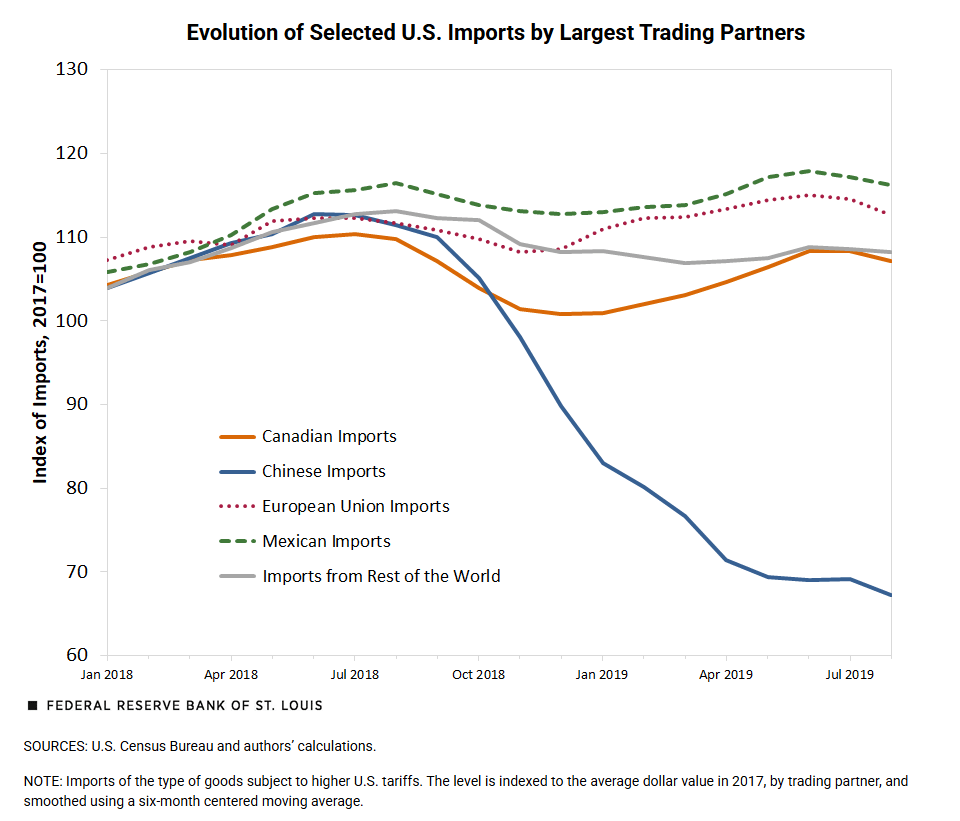Cosa vogliono davvero le persone, si domanda uno studio molto interessante pubblicato dal NBER che promette di offrire un contributo originale a quella che potremmo definire la madre di ogni domanda e che, inevitabilmente, ha a che fare con l’economia, se intendiamo l’economia nel senso che gli antichi davano a questa parola.
Va premesso che la risposta alla domanda che anima la ricerca arriva da un sondaggio svolto attraverso la piattaforma Amazon MTurk, uno dei tanti modi che abbiano trovato per far lavorare quanta più gente possibile pagandola il meno possibile (alcune stime parlano di meno di tre dollari l’ora), e questa è già una notizia che dovrebbe farci riflettere, specie quando leggiamo che una delle cose che le persone desiderano più di ogni altra è la stabilità economica.
Ma neanche la più importante, a dire il vero. Di gran lunga più importante, per chi li ha, è la salute dei figli e poi la propria, e questo ci dice molto più di quello che sembra sulle priorità medie delle persone e sul perché i figli in circolazione siano sempre meno. Un’importanza così elevata implica un investimento emotivo altrettanto considerevole, ancora prima che economico. E sempre meno hanno intenzione di spendere tempo ed energia per un figlio quando potrebbero più facilmente godersi la vita.
A proposito. La vera sorpresa è osservare quanto sia basso, nel ranking delle priorità degli intervistati, il desiderio della felicità, che pure ha animato persino carte costituzionali. Le persone la scambiano tranquillamente con salute e stabilità economica, che forse, stando così le cose, sono l’autentica base della felicità. E questa è una interessante indicazione per governi e produttori delle infinite sciocchezze delle quali ci circondiamo. Siamo esseri assai più semplici di come la politica e la pubblicità amano raffigurarci. E magari siamo persino più felici se dobbiamo sudarci un po’ quello che ci serve davvero.
La felicità insomma, a quanto pare, ha un basso rendimento marginale. Quando si tratta di rinunciare a qualcosa per ottenere qualcos’altro, il benessere soggettivo, quello che viene registrato nei sondaggi come “soddisfazione di vita”, vale poco. Al contrario, la salute dei figli, la stabilità economica, l’autonomia personale e le relazioni familiari si impongono come i veri beni rifugio del desiderio umano. Soprattutto quando si misura non il benessere dichiarato, ma quello scambiato: quanta felicità saresti disposto a sacrificare per migliorare la tua salute mentale? O per garantire una pensione dignitosa a tua madre?
Il lavoro si muove lungo questa linea: smontare la felicità come unità di misura e mettere al suo posto qualcosa di più solido, osservando le rinunce che siamo disposti a fare. E quando la posta in gioco è scegliere fra aspetti della propria vita – salute, relazioni, lavoro, denaro – allora si scopre che l’utilità, quel concetto un po’ sbiadito dell’economia classica, può tornare utile. Anzi, necessario.
La scala dei desideri che ne risulta è sorprendente e insieme ovvia. In cima, ci sono gli altri: i figli, i genitori, le persone care. Subito dopo, la salute, mentale e fisica. Più in basso, l’autorealizzazione, il successo, il tempo libero. E in fondo, la felicità, o meglio: l’idea generica di essere soddisfatti della propria vita. È come se le persone dicessero: “Sì, mi piace essere felice, ma se devo scegliere, preferisco stare bene davvero, garantire stabilità a chi amo, non dovermi preoccupare per il futuro”. L’economia della cura, più che quella dell’intrattenimento, succedaneo del piacere.
C’è poi un altro dato interessante. Le differenze tra individui sono molto più grandi di quelle tra gruppi. A contare non è tanto se sei uomo o donna, giovane o anziano, ricco o povero. Ma chi sei tu, con le tue esperienze, le tue mancanze, i tuoi bisogni. E ancora: i desideri più forti si concentrano sugli aspetti dove le persone si sentono più deprivate. Se hai poca salute mentale, la vuoi di più. Se ti senti isolato, dai più valore alle relazioni. Non è solo teoria economica: è teoria della domanda applicata alla vita. Il desiderio nasce dalla distanza tra dove sei e dove vorresti essere. L’utilità marginale, in fondo, è una misura della mancanza.
Perché tutto questo conta? Perché indica una direzione diversa per le politiche pubbliche. Se vogliamo davvero migliorare il benessere delle persone, forse non dobbiamo chiedere loro quanto sono felici, ma cosa sarebbero disposti a sacrificare per cambiare la propria vita. E poi agire su quei fronti: salute, sicurezza economica, supporto alle famiglie. Non serve un nuovo indicatore, serve un nuovo ascolto.
Questo studio non ci dice solo cosa desideriamo. Ci dice anche quanto poco ascoltiamo le persone e sappiamo delle loro priorità. L’economia, quando torna a parlare di desideri invece che di curve, torna anche a parlare di persone. Ma se nessuno ascolta le persone, l’economia è solo un arido gioco di numeri. Buono per i governi, appunto, e le loro politiche deficit-spending, e la pubblicità. Buoni per quelli che credono che basti riempirci di roba per essere felici e neanche pensano per un attimo al fatto che la felicità è un attimo, come diceva una vecchia pubblicità. E forse neanche così interessante.