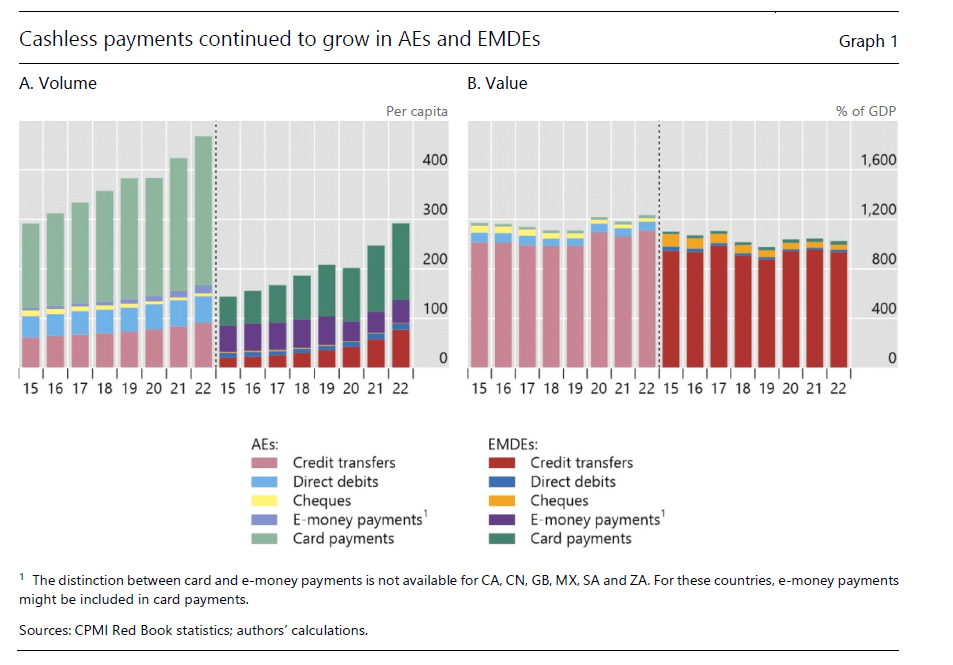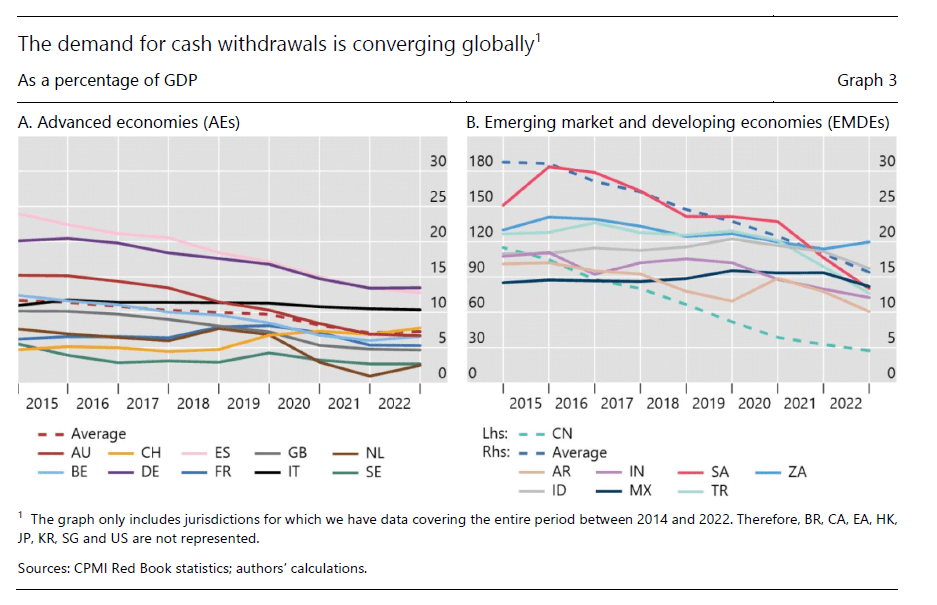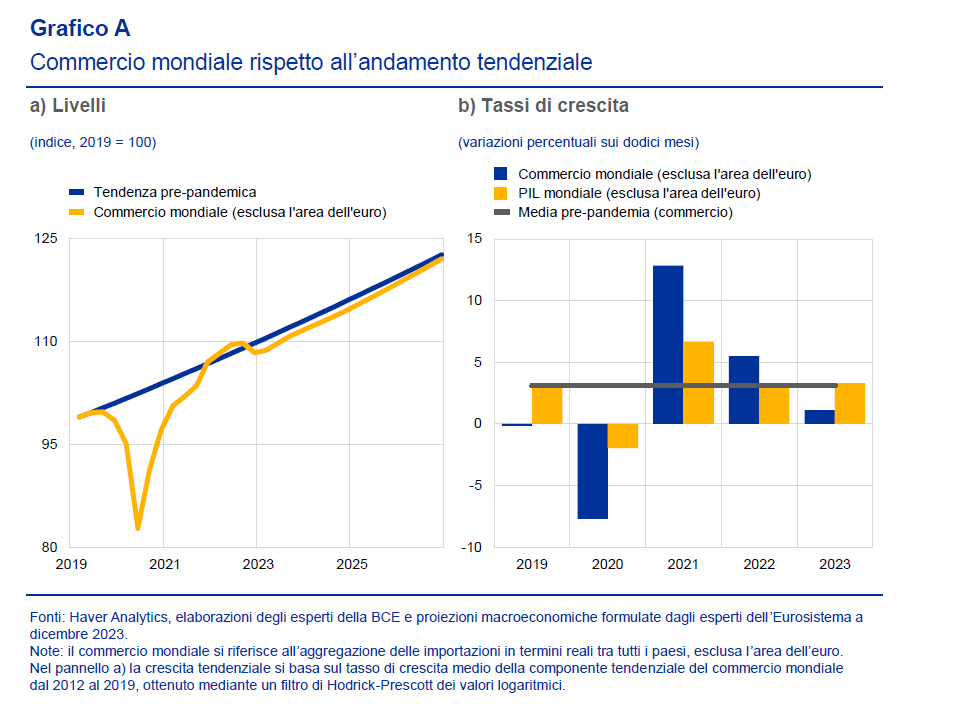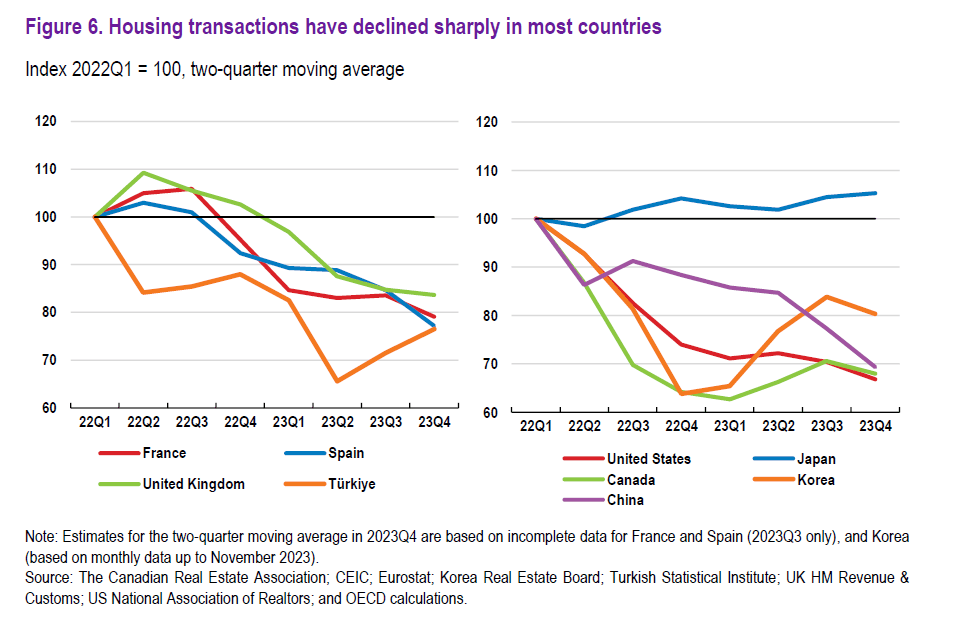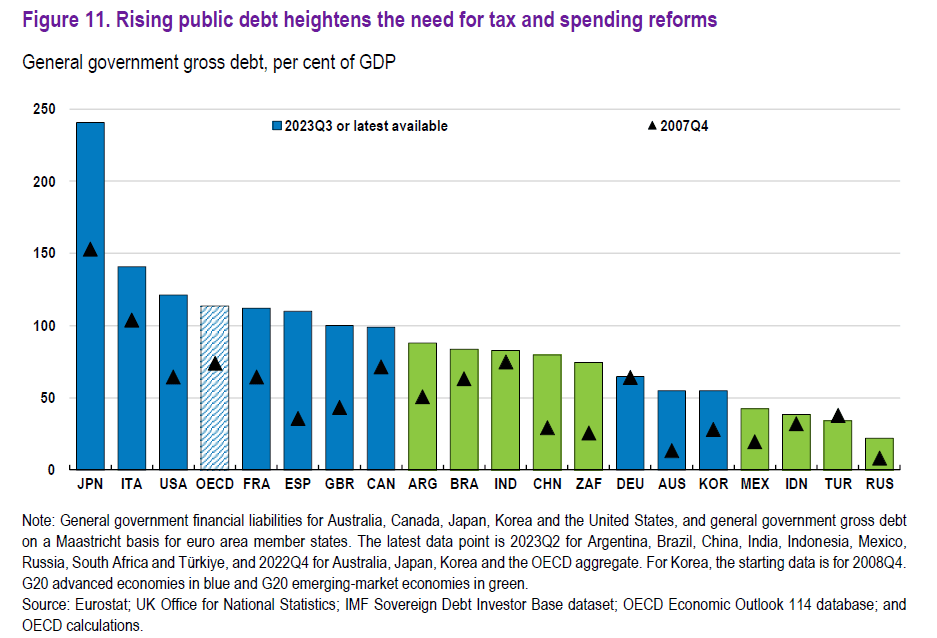L’economia nell’età degli “algorithms spirits”

Poiché lo spirito del tempo vuol convincerci che le macchine fanno, e soprattutto faranno, meglio degli uomini nelle cose difficili della vita, riservando a noi tutti un tranquillo pascolo nel vasto parco dell’intrattenimento (rimanendo un grande interrogativo su chi lo paghi), è davvero utile dedicare un po’ di tempo alla lettura di un paper diffuso di recente dal Nber intrigante già dal titolo: “The unreasonable effectiveness of algorithms”.
Parlare di “irragionevole efficacia” riferita al calcolo automatico è già di per sé un’esca sufficiente per sfogliare lo studio. Ma dentro c’è molto di più. C’è un’altra bellissima domanda che ha ispirato il titolo di questo post che da sola vale il paper: “Siamo in preda, come direbbe Keynes, agli spiriti algoritmici”?
Il riferimento era ovviamente agli animals spirits che l’economista inglese scomodava nella sua Teoria generale per provare a spiegare il temperamento che animava i cacciatori di opportunità che attivavano gli investimenti. Spiriti animali ieri, spiriti meccanici oggi.
Ottima domanda, quindi, quella degli autori. Quanto a questi ultimi, ci sono pochi dubbi. Sono praticamente posseduti: “Almeno nell’ambito delle applicazioni di policy, gli algoritmi ricevono troppa poca attenzione, non troppa”. Quindi evviva gli algoritmi. Datecene ancora.
Per capire questa estasiata considerazione, bisogna sforzarsi di entrare un po’ nel tecnico, ma non temete: basta un breve esempio: quello di utilizzo di algoritmi nell’elaborazione di alcuni problemi di policy, come quello di classificare l’efficienza di alcuni corsi di selezione nei college. “Se un corso è troppo difficile, lo studente può decidere di abbandonarlo, se è troppo facile può rivelarsi una perdita di tempo e denaro. Usare un algoritmo per predire il successo nella selezione di corsi può generare non solo grandi benefici, ma anche un “pasto gratis” per il governo”. Nel senso che l’efficienza fiscale della spesa del governo nel caso in ispecie è teoricamente infinita.
Senza bisogno di addentrarci troppo nella tecnica, che è il rifugio di chi ama pattinare sulla superficie delle cose, prendiamo in esame un altro caso citato nel paper: quello dell’utilizzo di algoritmi per prendere decisioni preliminari all’interno dell’amministrazione della giustizia o addirittura nell’elaborazione di test medici per i pazienti.
Il risultato è analogo; questi strumenti producono un margine di efficienza fiscale infinito e quindi una sorta di “pasto gratis” per il governo. Questa cuccagna è talmente sorprendente che persino gli autori osservano come “i numeri relativi al rapporto costo-efficacia degli algoritmi non sono solo straordinariamente elevati; potrebbero anche sembrare irragionevolmente grandi”.
E tuttavia, in qualche modo, questo risultato potrebbe essere sensato, osservano. Per almeno due ragioni. La prima è che gli algoritmi funzionano meglio degli uomini quando si tratta di ordinare alternative – ranking problem – secondo certe scale di priorità. Ossia ciò che di solito si fa nel calcolo economico per poter scegliere la cosa migliore da fare.
La seconda ragione è che gli algoritmi possono sfruttare economia di scala, quindi lo stesso software può girare all’infinito, qualunque sia il problema, con un costo marginale decrescente.
Chi fosse curioso, può tranquillamente leggere il paper e approfondire per conto suo. Qui ci limitiamo a due brevi considerazioni epistemologiche.
La prima è che la filosofia che sta dietro l’utilizzo di questi strumenti non è diversa dall’utilitarismo settecentesco. Si presume che un soggetto debba compiere scelte razionali, ossia calcolabili, per massimizzare l’utilità, e quindi il profitto. Solo che siccome il computer è più bravo di noi umani a calcolare, conviene che se occupi lui al posto nostro. Ne avremo addirittura “pasti gratis”.
La seconda osservazione è un promemoria. Continuiamo a credere che pensare significhi calcolare alternative, magari in chiave probabilistica. Ossia che l’uomo sia riducibile alla macchina. Ne parleremo in un libro di prossima uscita. Ma intanto vale la pena ricordare che il computer, o per meglio dire l’idea della computazione, che ha generato gli algoritmi, nasce dal paradigma funzionalista di moda nella metà del secolo scorso che ha semplificato all’estremo alcune caratteristiche degli esseri umani – ad esempio la nostra consuetudine con gli operatori logici – al fine di ridurre la realtà a una rappresentazione binaria/digitale. Da qui a scambiare una realtà binaria, quindi di tipo on/off, per la realtà il passo è stato rapidissimo. E altrettanto incompreso quanto agli effetti. Uno per tutti: ci siamo talmente convinti che la l’uomo somigli alla macchina che siamo studiando come farla somigliare sempre di più all’uomo credendo che sia davvero possibile.
Ciò per dire che sarà pure vero che le macchine offrono “pasti gratis”. Ma questo non vuol dire che poi sia anche reale (se qualcuno ancora percepisce questa differenza). E, soprattutto, che questi pasti siano davvero capace di saziarci.