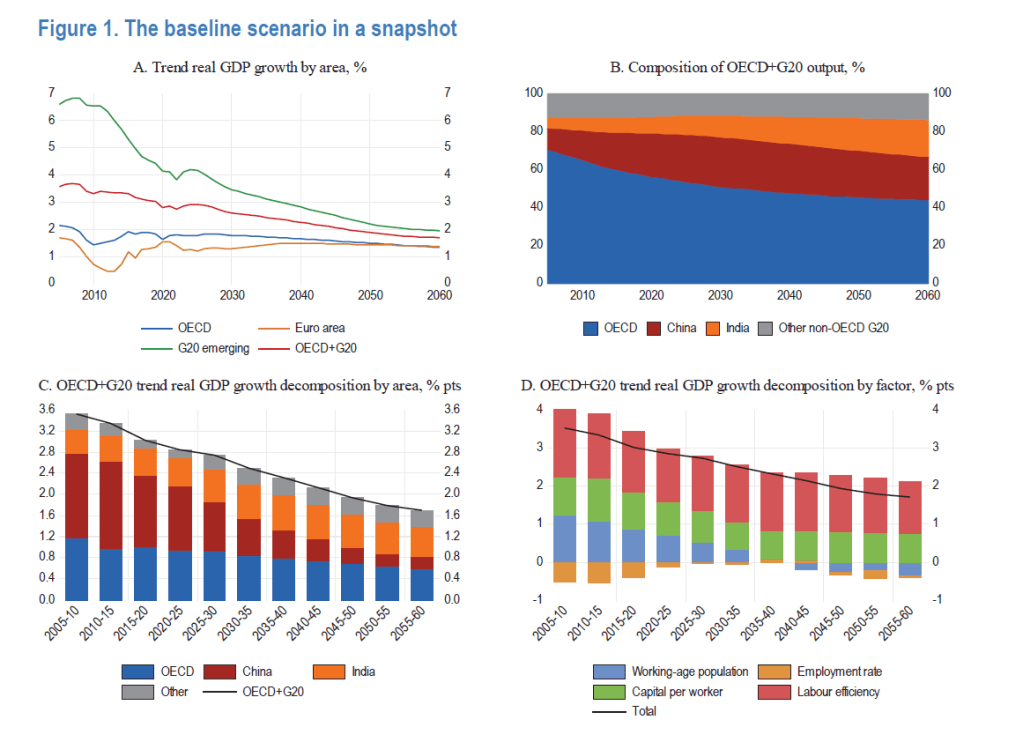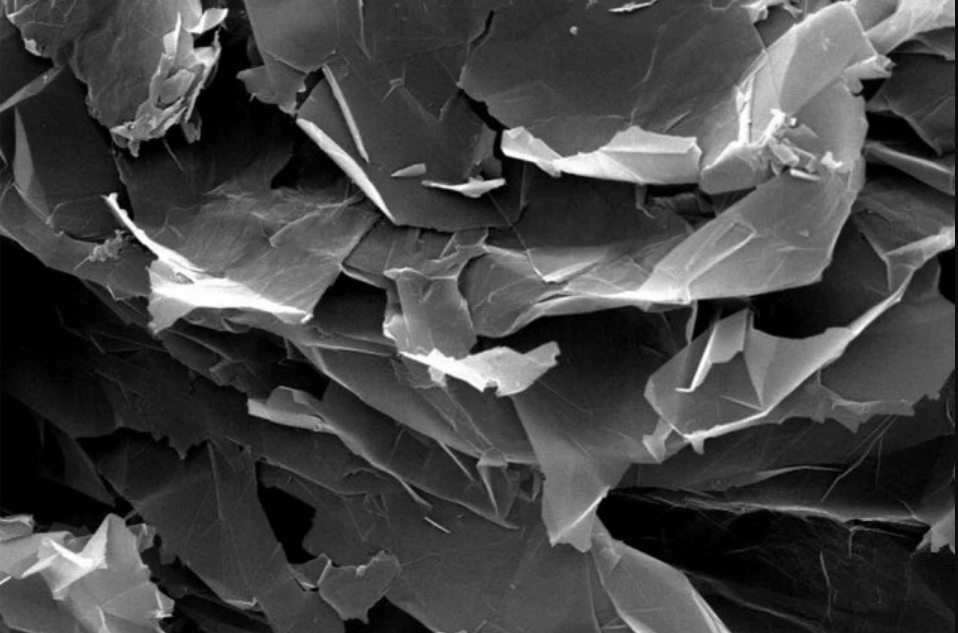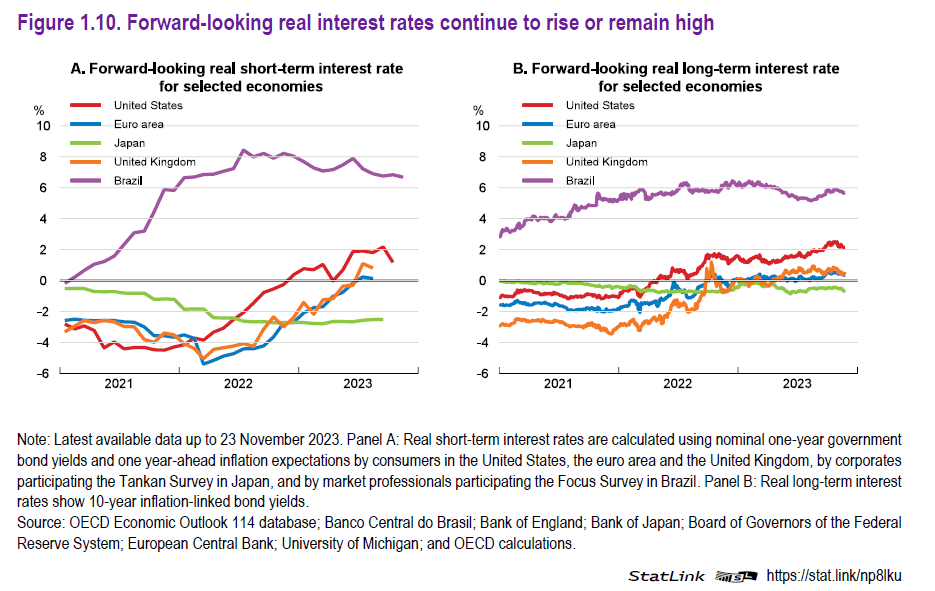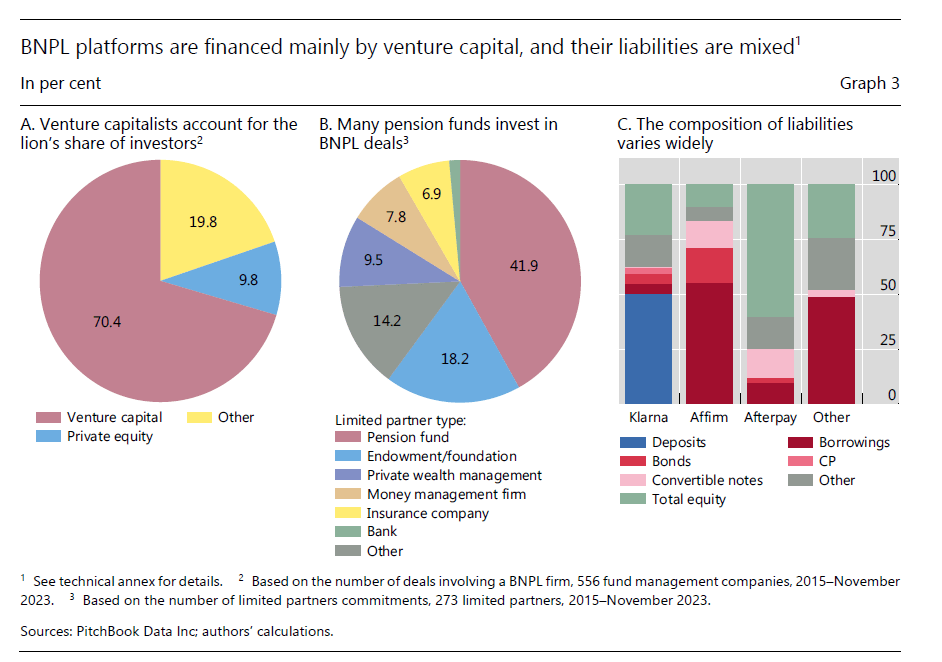La poco felice conclusione della lunga telenovelas del Mes, che l’Italia ha deciso di bocciare perché si è fissata col dito e ha scelto con poco giudizio di ignorare la direzione, ci dice molto della difficoltà nella quale si agita l’idea europea, fragile costruzione esposta ai venti turbinosi dei capricci dei singoli stati nazionali. Discutere di allargamento, quando ancora non sappiamo gestire problemi come quello del Mes significa semplicemente aggiungere elementi di instabilità a un quadro già dissestato. Come dice il proverbio, più sei grosso, più fai rumore quando cadi. E nessuno di noi ha voglia di vedere ingrossare l’Europa solo per finire assordato dal rumore della sua caduta.
Poiché è del tutto inutile aggiungersi al rumore di fondo che già disturba le nostre cronache, ci limitiamo qui a proporre una breve riflessione sul passato dell’Europa, che pure offre preziose suggestioni. Un semplice promemoria che delinei anche una prospettiva. Un modo per provare ad armonizzare la storia dell’Europa con la sua geografia.
Partiamo dal presente. La costruzione europea, la cui forma più avanzata che include la condivisione della moneta è quella dell’Eurozona, è una curiosa creatura istituzionale che non arriva a esprimere una fisionomia compiuta. Non è una federazione, come gli Stati Uniti, ma neanche una confederazione, come quella Svizzera. Somiglia più a una comunità d’intenti, che nel tempo è riuscita a strutturare una costituzione economica, ma anche questa in modo ancora parziale.
Per completarla sarebbero necessarie un’unione bancaria e un’unione del mercato dei capitali, per avere non solo una politica monetaria comune ma anche una politica finanziaria comune e, soprattutto, un mercato univoco dei titoli sovrani, come il mercato dei Treasury statunitensi. Di Unione Bancaria e del Mercato dei capitali si parla da anni, ma siamo ancora lontani dal vederli attuati. Il risultato di questo tentennare è che l’Europa si presenta a ogni crisi come un interlocutore polifonico. Alla voce delle istituzioni europee si sovrappongono, spesso in maniera dissonante, quelle dei singoli stati nazionali. L’Europa, per ricordare una celebre espressione, sembra un’espressione geografica declinata maldestramente dagli stati che la compongono.
Di fronte al mondo, perciò, l’Europa non appare un interlocutore solido con cui fare i conti, ma un universo composito, retto non si sa bene come da figure che hanno un riconoscimento istituzionale, delle quali però non sono chiari i reali margini di manovra. Viene percepita come un corpo intermedio: fra un’associazione e uno stato. Qualcosa di morbido in un mondo di solidi.
Non è la prima volta. Qualcosa di simile, anche se ovviamente con espressioni molto diverse, l’Europa l’ha conosciuta secoli fa: col Sacro Romano Impero del XVI-XVII secolo.
In quel periodo il sistema degli stati, formatosi durante il Medioevo nelle città italiane, si espanse generando il sistema degli stati europei dell’Età moderna. Fu un’epoca contrassegnata da gravi crisi che squassarono le coordinate dell’Europa medievale distruggendo le due universalità che avevano retto la storia fino ad allora: quella religiosa – con l’avvento della riforma protestante – e quella politica, con la messa in crisi dell’idea imperiale da parte delle nascenti nazioni europee.
Il sistema trovò un equilibrio sulle spoglie della distruzione dell’Europa centrale – ossia degli Stati tedeschi che erano il cuore del Sacro Romano Impero – dopo la Guerra dei trent’anni. Nacque il sistema di Vestfalia, che affermò il principio dell’identità nazionale su base territoriale. Paradossalmente il sistema contemplava anche l’esistenza di numerose entità statali germaniche spezzettate nel Sacro romano impero. La loro polverizzazione faceva da contrappeso alla pesantezza degli stati nazionali europei in formazione. Il Sacro Romano Impero era un gigantesco non-stato cuscinetto capace di assorbire le tensioni emergenti fra le grandi potenze laterali dell’Europa del tempo, quindi innanzitutto Francia, Inghilterra, la Spagna declinante e, più tardi, la Russia zarista.
Questo principio fu restaurato a Vienna, dopo le guerre napoleoniche, e messo in discussione dalla rivoluzione “antirivoluzionaria” di Bismarck. Il cancelliere, unificando la Germania, la “solidificò”: accese una bomba a frammentazione nel cuore dell’Europa, che l’espansione rese sempre più pericolosa.
Bismarck conosceva perfettamente i rischi. Per questo perseguì con scrupolo l’idea del concerto europeo delle nazioni per rassicurare i suoi interlocutori europei. Ma era una politica di corto respiro. Una volta divenuta un corpo solido, era solo questione di tempo prima che la Germania finisse in urto con le sue potenze laterali.
La bomba, perciò, scoppiò. L’esplosione generò la “Seconda guerra dei trent’anni” iniziata nel 1914, quando il sistema degli Stati europei deflagrò, devastando nuovamente la Germania, come era accaduto trecento anni prima e dando vita al sistema degli stati globali che ci accompagna oggi.
L’Europa di oggi somiglia al Sacro romano impero: una disunità che equilibra le potenze laterali, che ormai sono quelle Atlantiche e quelle Euroasiatiche, nei confronti delle quali l’Europa coltiva un comportamento ambiguo per la semplice ragione che in esse, a Ovest come ad Est, sono fioriti semi che provengono dal suo suolo. Il sedicente comunismo cinese e il cosiddetto capitalismo americano sono frutto di idee nate in Europa.
In sostanza, l’Europa è divenuta un gigantesco non-stato cuscinetto, che adesso dice di volere anche una sua autonomia strategica. E in questo risiedono infiniti pericoli. Una semplice analogia con la storia dovrebbe suggerire a noi europei molta prudenza e senso della realtà, mentre lavoriamo “bismarckianamente” alla nostra rivoluzione “antirivoluzionaria”. L’Europa di domani, qualora dovesse consolidare la sua forma istituzionale, potrebbe somigliare alla Germania del cancelliere di ferro. E un’Europa “germanizzata”, per dirla con Thomas Mann, deve sempre ricordare la propria storia per non commettere per la terza volta il suo errore fatale.
La storia dovrebbe ricordarci – e la tragedia ucraina è un ottimo promemoria – che le tensioni fra le potenze laterali tendono a scaricarsi sul centro, che ormai è l’intero territorio europeo. E la geografia suggerirci che è molto difficile sfuggire alla morsa della tenaglia Asiatico-Atlantica. Salvo proporci una soluzione. Che sta proprio sotto gli occhi dell’Europa: l’Africa.
Oggi si discute molto dell’Africa, e l’Ue ha il merito di portare avanti progetti importanti come il Global Gateway, attraverso il quale vuole proporre un suo nuovo ruolo nella politica internazionale. Ma adesso non si tratta più semplicemente di accompagnare lo sviluppo degli stati africani, fornendo denaro o know how. Qui si tratta di “fare” l’Africa, né più né meno. Ossia una nuova entità comune e riconoscibile nel panorama globale.
Bruxelles ha un’esperienza unica in tal senso. Sono decenni che persegue, all’interno dell’Europa con successi altalenanti, questo obiettivo. E’ la sorella maggiore ideale per interloquire con le nascenti istituzioni africane, – una per tutte, l’Unione Africana (UA) – che in qualche modo stanno camminando sulle sue tracce. Anche l’Africa, per fare un esempio, pensa da tempo a una moneta comune.
Questo passaggio richiede un cambio radicale di prospettiva. L’Ue dovrebbe rivolgersi preferenzialmente alle istituzioni africane assai più che ai singoli stati africani, che sono ancora molto coinvolti nel bilateralismo con i loro omologhi internazionali. L’UE può aiutare l’UA a promuovere l’idea e la pratica dell’Africa, che in un continente ancora devastato dai tribalismi somiglia a un’ottima panacea e a un’autentica rivoluzione. In questo trasferimento di esperienza e conoscenza l’Europa realizzerebbe il suo significato più alto, che è quello di essere una comunità di valori che guarda e vive aldilà delle frontiere fisiche, che sono un’ossessione degli stati nazionali. In un mondo che si popola di giganti di pietra, l’Europa a-nazionale deve diventare un gigante ideale capace di aiutare a crescere quel gigante-bambino che è l’Africa.
Perché tutto ciò non appaia astratto, concludiamo con un esempio. Da anni il governo spagnolo e quello marocchino discutono senza costrutto di un ponte o un tunnel che colleghi i punti più vicini di Spagna e Marocco. Un’idea che avrebbe effetti straordinari sui rapporti fra Europa e Africa. I governi nazionali non ne vengono a capo. Perciò l’UE dovrebbe far proprio il dossier, mettere sul tavolo le risorse e dialogare con l’Unione Africana per trovare un percorso comune di realizzazione. L’Africa ha bisogno di politiche di questo calibro. E anche l’Europa.