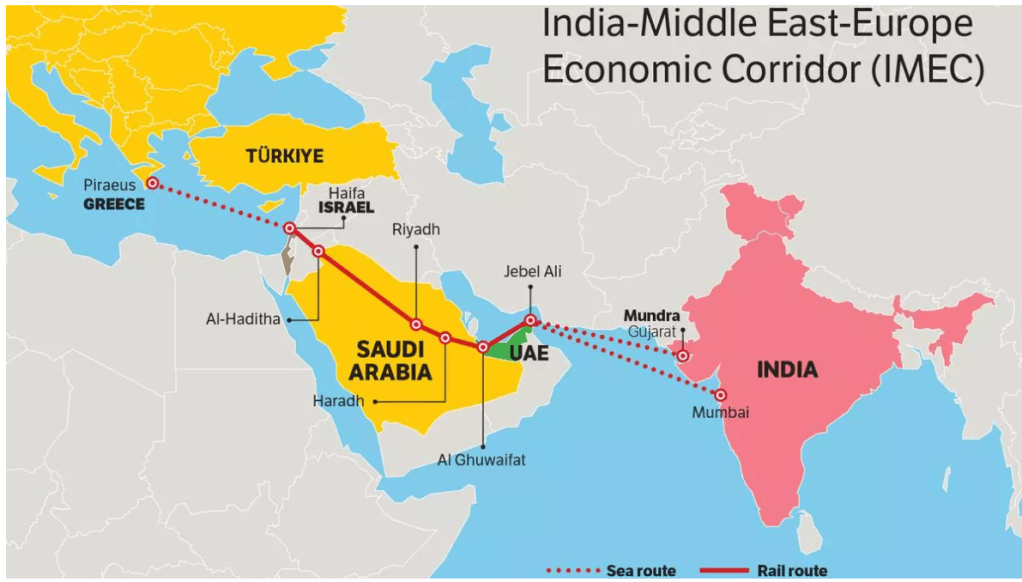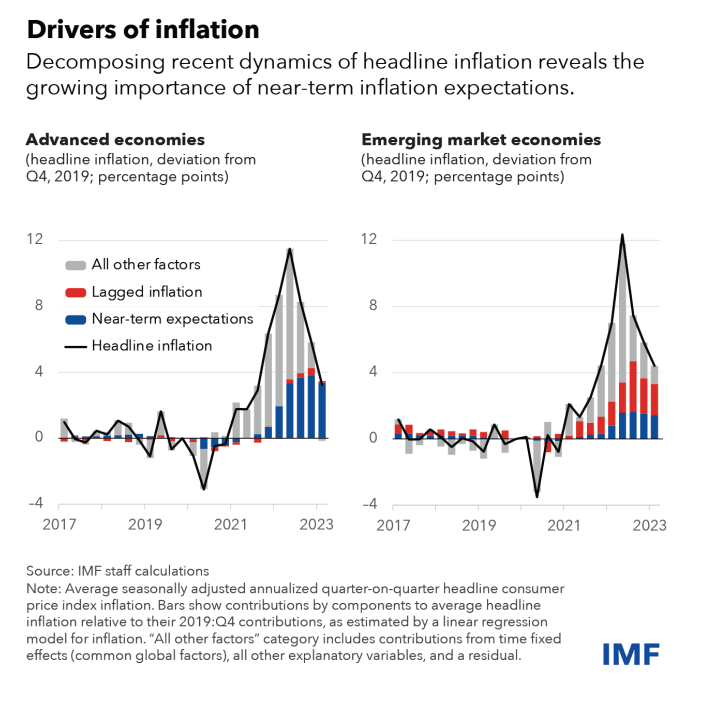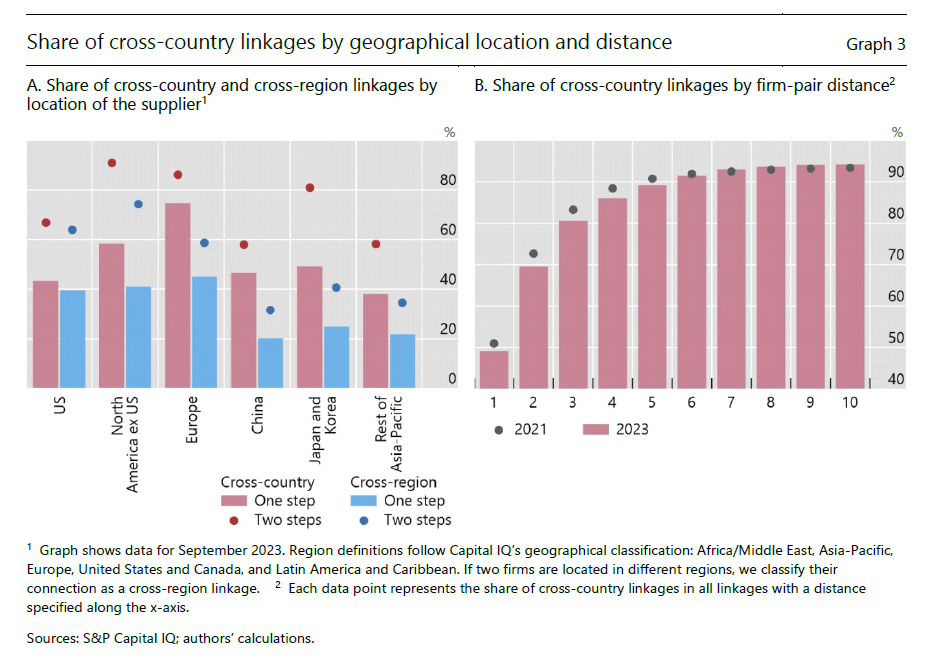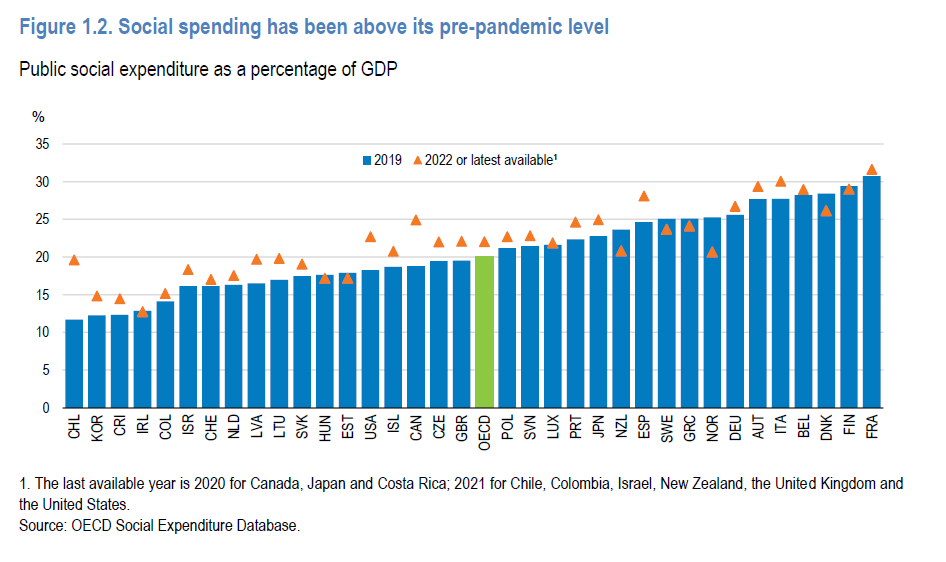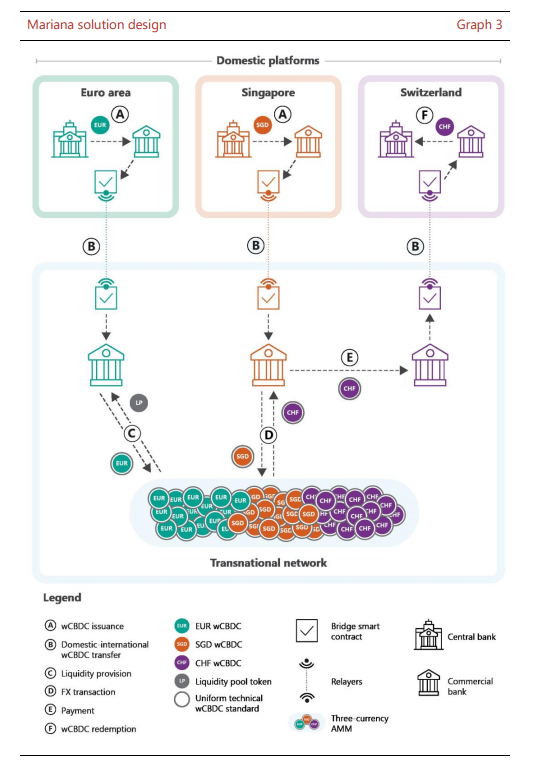La transizione (energetica) verso un mondo col 100% di debiti sul pil

Nel caso vi fosse sfuggito, e ammesso che vi interessi, pochi giorni fa il Fmi ha rilasciato il suo Fiscal monitor, tutto dedicato alla transizione energetica, dove si legge che entro il decennio il mondo arriverà ad esprimere un debito globale pari al 100 per cento del pil.
E che sarà mai, direte. Noi italiani l’abbiamo superato da tantissimo tempo e viviamo benissimo. Benissimo: oddio. Salvo tormentarsi per ogni manovra finanziaria, sperare nella compiacenza delle banche centrali e degli investitori internazionali, vivere il batticuore dello spread, stiamo benissimo in effetti. E allora di cosa dovrebbe preoccuparsi il mondo?
Preoccuparsi magari no, ma occuparsi magari del fatto che le due maggiori economie globali, ossia Usa e Cina contribuiscono talmente a questa crescita del debito che se le escludiamo dal computo il rapporto debito/pil, stimato in crescita dell’1 per cento l’anno fino al 2030, crescerebbe della metà. Detto diversamente: siamo tutti ostaggi del mal di pancia sino-americani, che trovano abbondantemente di che alimentarsi in un contesto di crescita che rallenta e di costo del debito che sale, il che non è certo un buon viatico per la sostenibilità di un debito crescente. E da quando le banche centrali hanno smesso di tenere i tassi bassi la sostenibilità è diventata un affare assai più complicato di prima.
In questo mondo, che si avvia verso un debito complessivo pari al prodotto, si inserisce con la forza di un meteorite la transizione energetica, di cui sappiamo nulla tranne che sarà costosissima. Ed è per questo che, scrive Vitor Gaspar, direttore del dipartimento fiscale del FMI, nella sua introduzione al rapporto, “il settore privato ha un ruolo cruciale da giocare”.
Il che è sicuramente vero. Ma chi ha memoria lunga e qualche annetto sulle spalle, ricorderà che il privato è bravissimo a socializzare le perdite, piuttosto che i guadagni e che i suoi calcoli economici difficilmente coincidono col benessere collettivo.
Nulla vieta, ovviamente, di provare a incoraggiarli, questi benedetti privati, a darci una mano nel nostro viaggio verso un mondo meno inquinato. Ma sempre l’esperienza ci insegna che le transizione energetiche – ad esempio quella dal carbone (che ancora si usa) al petrolio (che si userà ancora a lungo) sono stati guidati dalla fame di profitto, non certo dalle preoccupazioni ambientali. La fame di energia ha quasi condotto al disboscamento dell’Europa, alcuni secoli fa.
Perciò ben vengano i privati, ma serve anche un piano b, specie quando il debito globale si avvicina verso il livello di guardia. Il Fmi sta spingendo i suoi numerosi membri a migliorare il proprio sistema fiscale, da dove si presuppone debbano arrivare i fondi per pagare il biglietto del viaggio verso un mondo più fresco. Ma i singoli paesi sono già spremuti abbastanza (valga sempre il nostro come esempio).
Al tempo stesso si parla ancora di global saving glut, ossia di eccesso di risparmio che adesso, coi nuovi tassi sarà molto felice di finanziare a caro prezzo i governi. Forse se questi risparmiatori potessero investire su strumenti sovranazionali – modello next generation Ue, per intenderci – potrebbero pure rinunciare a qualche decimo di rendimento per lasciar dormire più tranquilli i propri capitali. I privati magari collaborano più volentieri se sono sicuri di guadagnarci, anche meno se rischiano meno. Ma per convincerli serve un progetto complessivo, davvero sovranazionale, che coinvolge le principali economie del pianeta. E questo è un lavoro per i governi, non certo per i privati.