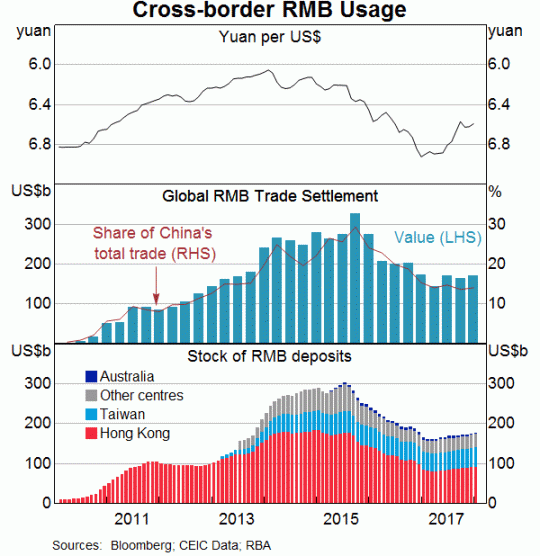L’incognita cinese nella sfida al dollaro
L’avvicinarsi dell’avvio del secondo round di sanzioni volute dagli Usa contro l’Iran consente già di capire che questo evento, importante ma non certo determinante nell’ampio contesto delle relazioni internazionali, ha un sottotesto economico assai interessante da osservare. Da quando l’avvio delle sanzioni, che arriverà nei primi giorni di novembre, è divenuto imminente, gli elementi di riflessione si sono moltiplicati emergendo qua e là in resoconti più o meno interessati che naturalmente spaziano dai mercati petroliferi, nei quali l’Iran è un notevole protagonista, a quelli finanziari. Le due cose sono intrinsecamente collegate, com’è ovvio che sia e che solo una certa cattiva letteratura, che alimenta il mito che economia reale ed economia finanziaria siano cose diverse e persino divergenti, tende a dimenticare. L’Iran vende petrolio (bene reale) e quindi genera flussi di denaro (bene finanziario). Il problema è che non si sa bene come farà l’Iran a vendere un bene reale solitamente quotato in dollari una volta che il suo mondo finanziario, del quale la sua banca centrale è la prima attrice, verrà tagliato fuori dal sistema finanziario denominato in dollari.
Non è un problema banale. Molti ricorderanno la dichiarazione del rappresentante europeo per gli Affari esteri Federica Mogherini secondo cui l’Ue stava pensando di creare un veicolo finanziario per regolare le transazioni fra l’Iran e i paesi europei che ancora si riconoscono nell’accordo siglato a suo tempo con l’Iran e disdettato unilateralmente da Trump. Aldilà di ciò che farà l’Europa – la mossa della Mogherini poteva avere un semplice fine tattico – rimane aperta la questione di chi comprerà il petrolio iraniano allo scattare delle sanzioni e soprattutto di come lo pagherà. E ovviamente l’attenzione è tutta puntata sulla Cina che del greggio iraniano è il primo acquirente. Il comportamento di Pechino non è di semplice lettura. Secondo quanto trapela dalle cronache, alle notizie secondo le quali la Cina avrebbe continuato a comprare il petrolio iraniano, per giunta rilanciate anche da importanti esponenti del business energetico russo, sarebbero seguiti comportamenti di senso opposto. Secondo alcune fonti la Cina avrebbe già tagliato la domanda di greggio dall’Iran. La principali raffinerie di stato cinesi, infatti, non avrebbero chiesto greggio a novembre. Ma soprattutto sulla stampa è venuta fuori la notizia che la Cina avrebbe detto alla Banca di Kunlun di smettere di ricevere pagamenti dall’Iran.
La storia merita un approfondimento, perché illustra come abbia funzionato fino ad ora il rapporto finanziario fra la Cina e l’Iran. La banca di Kunlun è controllata dal gigante energetico cinese CNPC. Sempre secondo alcune indiscrezioni riportate da Reuters, la banca avrebbe già sospeso ad agosto i pagamenti denominati in euro dall’Iran e adesso avrebbe deciso anche di sospendere quelli denominati in yuan. In sostanza la repubblica islamica non sarebbe più in grado di scambiare valuta con la Cina tramite questa banca. E’ difficile capire in che modo questa decisione impatterà sul futuro delle vendite di petrolio, ma di sicuro non le semplifica. Basta ricordare che questa banca fu fondata nel 2006, acquistata dalla CNCP nel 2009 e da allora trasformata nel principale strumento cinese per gli affari con l’Iran. In tal modo i cinesi evitarono sanzioni alle altre banche nazionali nel periodo 2010-15 quando la repubblica islamica era sotto sanzioni, che ovviamente non risparmiarono la Kunlun, che nel 2012 su sanzionata dal Tesoro Usa proprio per i suoi affari iraniani. Di conseguenza la banca fu esclusa dai circuiti di pagamento denominati in dollari e fu “costretta” a regolare i suoi pagamenti in euro e yuan. Cosa è cambiato dal 2012 a oggi? La tensione crescente con l’amministrazione Trump può aver indotto la Cina a una maggiore prudenza rispetto al passato?
Qualche risposta arriverà dopo il 5 novembre, quando scatterà il nuovo round di sanzioni Usa contro l’Iran. Ma al di là di come si comporterà la Cina nell’immediato, Pechino deve far fronte a un dilemma finanziario rilevante che nasce dalla sua notevolissima fame di commodity: la sua dipendenza dal dollaro proprio per gli acquisti di questi beni. Secondo alcune stime la Cina spende ogni anno circa 350 miliardi di dollari per comprare le materie prime di cui ha bisogno, a cominciare ovviamente dal petrolio. Un conto destinato ad aumentare se la Cina vorrà proseguire nella sua visione di espansionismo economico internazionale. Ciò spiega perché il paese stia investendo massicciamente per aumentare il suo peso specifico finanziario nel mercato delle commodity. Di questo attivismo sono disseminate le cronache. Il fatto più rilevante che molti ricorderanno è sicuramente la quotazione dei future sul petrolio in yuan, che ormai ha compiuto rilevanti passi in avanti. Ma rimane il fatto che fino ad oggi la sua bolletta per le materie prime la Cina deve pagarla in dollari. E ciò significa che ha bisogno di guadagnare tanti dollari. E soprattutto che ha bisogno del sistema bancario che usa i dollari – a cominciare da quello americano – per effettuare i suoi regolamenti. L’ostilità statunitense, in tal senso, è un duplice problema per i cinesi. Da un lato gli Usa comprano ogni anno dai cinesi quasi 500 miliardi di beni. Acquisti che Trump ha preso di mira. Dall’altro questi pagamenti sono regolati dal sistema bancario Usa, l’accesso al quale, di conseguenza, è vitale per la Cina.
Sottrarsi a questo giogo, che è innanzitutto finanziario, non è per niente semplice. La Cina sta spingendo molto sui processi per internazionalizzare la sua moneta, che infatti ormai ha un peso specifico rilevante in tutta l’area asiatica e persino in Australia.
E’ chiaro però che questo processo è fortemente impedito dalla circostanza che la valuta cinese non è convertibile. Per questa ragione la banca centrale australiana, che all’internazionalizzazione del Renmimbi ha dedicato di recente un paper molto interessante, arriva alla conclusione che la valuta cinese ormai sia pronta a emergere come valuta di peso regionale e ovviamente “un maggiore uso del RMB a livello internazionale potrebbe accompagnare l’apertura del conto capitale e la riforma del mercato finanziario in Cina”. E proprio l’Australia sarebbe il primo paese anglofono a “attrarre anche un maggiore volume di flussi finanziari dalla Cina”. “Uno yuan più internazionalizzato dovrebbe assumere un ruolo più prominente nelle transazioni economiche e finanziarie australiane”, osserva la banca.
Se mai succederà che lo yuan sarà libero di circolare, in sostanza, il gioco multivalutario non sarà più soltanto un astruso passatempo da specialisti. La Cina, che già quota in valuta nazionale molte commodity, avrebbe uno strumento in più per convincere i suoi venditori di materie prime, che sono russi, centro asiatici, mediorientali, australiani e africani, ad accettare lo yuan come moneta di pagamento, forte del fatto che è una grande consumatrice di materie prime e una grande creditrice di molti di loro. La sfida al dollaro a quel punto, e al sistema che trova nella denominazione del commercio internazionale uno degli strumenti del potere del dollaro, sarebbe molto più che un’ipotesi. Sarebbe nei fatti. E l’Europa dovrà scegliere da che parte stare.
(3/fine)
Puntata precedente: La seduzione dell’euro per il petrolio russo